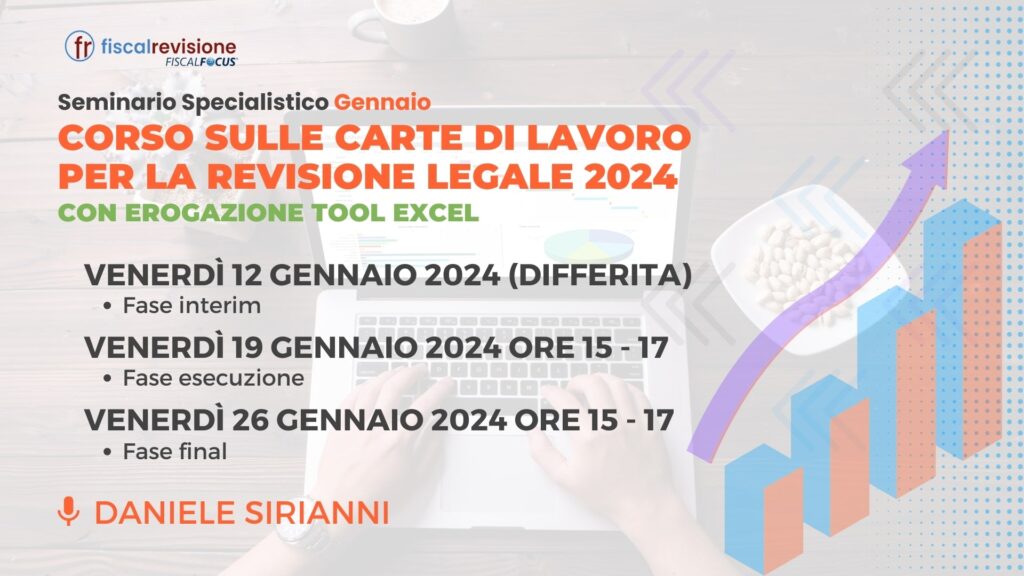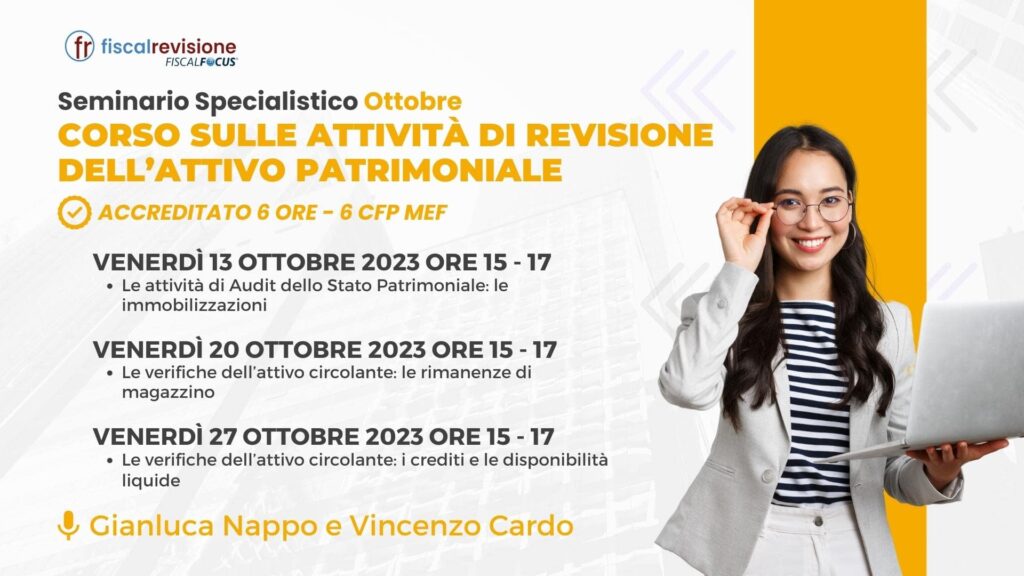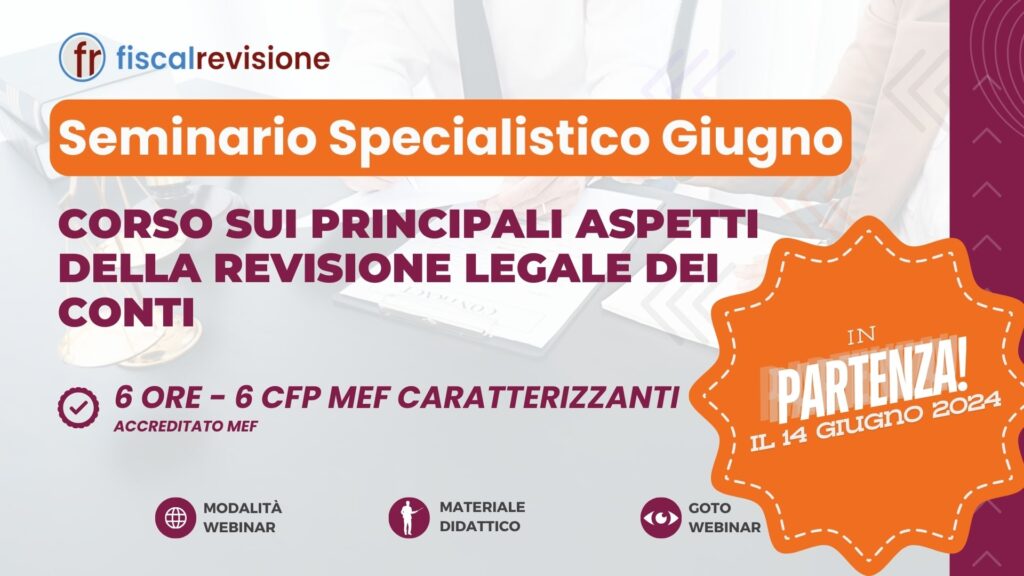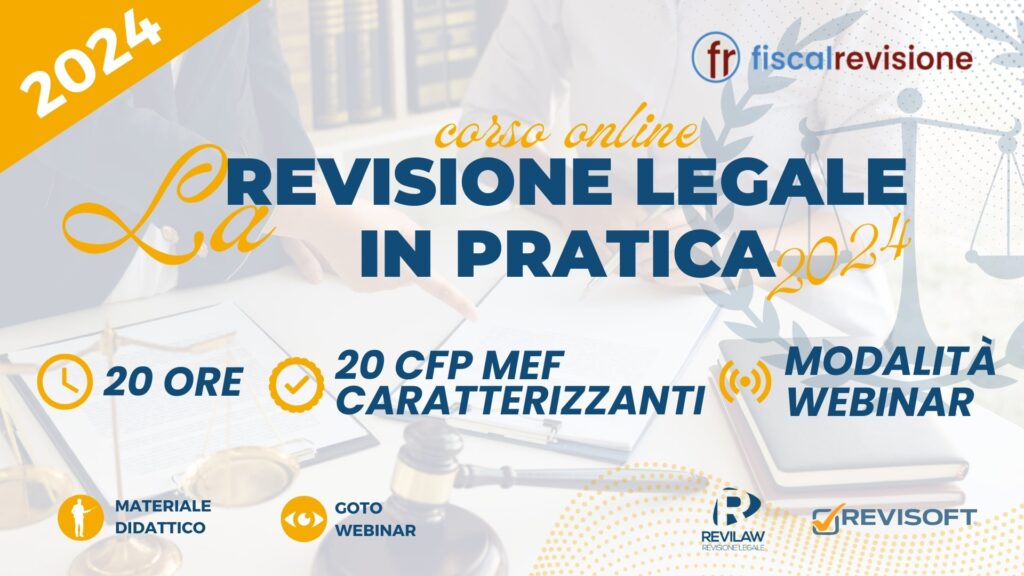Il recente decreto di riforma del TUF, approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente all’esame del Parlamento, ha introdotto un’importante precisazione: la nuova disciplina sulla responsabilità dei sindaci per colpa professionale non si applica alle società quotate.
Viene così creato un sistema “a doppio binario”, con regole diverse a seconda che l’ente sia quotato o meno. Per le società quotate resta infatti esclusa la limitazione economica prevista dal nuovo articolo 2407 del Codice civile, mantenendo un livello di tutela più elevato per gli investitori e i mercati finanziari.
Il legislatore ha ritenuto che la complessità della governance e la maggiore diffusione del rischio nelle società con capitale frazionato rendano incompatibile qualsiasi compressione della responsabilità dei sindaci. Il principio di piena responsabilità patrimoniale, dunque, rimane fermo per le società soggette alla vigilanza dei mercati regolamentati.
La riforma per le non quotate: la Legge 35/2025
Diversa invece la situazione per la gran parte delle imprese italiane — le società non quotate — per le quali la Legge 35 del 14 marzo 2025, in vigore dal 12 aprile, ha riscritto profondamente il regime di responsabilità dei sindaci.
L’obiettivo è quello di bilanciare la tutela della società, dei soci e dei creditori con l’esigenza di contenere l’esposizione patrimoniale dei professionisti, delineando un quadro di maggiore prevedibilità e sostenibilità del rischio.
1. Le innovazioni chiave della riforma
La nuova formulazione dell’articolo 2407 del Codice civile introduce tre grandi novità.
Eliminazione della responsabilità solidale espressa.
Scompare ogni riferimento testuale alla solidarietà tra sindaci e amministratori per le condotte di questi ultimi. La norma elimina così un meccanismo che, nella prassi, aveva spesso trasformato la funzione di vigilanza in una responsabilità “oggettiva”.
Tuttavia, la solidarietà può ancora operare in via indiretta, laddove il danno derivi da un omesso controllo, in base alla regola generale dell’articolo 2055 c.c.
Limitazione del quantum risarcibile.
Per la prima volta viene introdotto un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, calcolato come multiplo del compenso annuo percepito:
- fino a 10.000 euro: 15 volte il compenso;
- tra 10.000 e 50.000 euro: 12 volte il compenso;
- oltre 50.000 euro: 10 volte il compenso.
Tale limite si applica anche in caso di colpa grave, ma non nei casi di dolo.
Nuova decorrenza della prescrizione.
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive in cinque anni dal deposito della relazione al bilancio (art. 2429 c.c.), allineando così la disciplina a quella prevista per i revisori legali.
2. Le prime interpretazioni giurisprudenziali
Una delle prime letture ufficiali è arrivata con l’ordinanza n. 1981 del Tribunale di Bari del 24 aprile 2025, che ha offerto chiarimenti su alcuni nodi cruciali.
- Compenso “percepito”. Il riferimento va inteso come compenso deliberato in assemblea o previsto dallo statuto, e non necessariamente incassato, per evitare comportamenti elusivi.
- Retroattività del limite. La limitazione del quantum ha natura procedimentale e si applica anche a condotte anteriori alla riforma; la nuova prescrizione, invece, ha natura sostanziale e vale solo per i fatti successivi.
- Calcolo del danno. Il limite si applica a ciascuna condotta dannosa, e non in modo cumulativo per l’intero mandato.
Il Tribunale ha inoltre richiamato la sentenza n. 115/2024 della Corte Costituzionale, che, in tema di revisori, ha chiarito che la prescrizione dal deposito della relazione vale solo per l’azione promossa dalla società, non per quella di soci o terzi.
3. Le criticità della disciplina
Pur rappresentando un passo avanti nel contenimento del rischio professionale, la riforma solleva numerose criticità interpretative e sistemiche.
Scaglioni non progressivi.
Il sistema dei moltiplicatori può produrre effetti paradossali: un compenso di 9.500 euro genera un’esposizione massima di 142.500 euro, superiore a quella di un compenso di 10.500 euro (126.000 euro).
Disparità con i revisori legali.
I sindaci che svolgono anche la revisione legale (art. 2409-bis c.c.) beneficiano del limite, mentre i revisori esterni restano soggetti a responsabilità illimitata. Una differenza che mina l’omogeneità della tutela e apre il campo a possibili profili di illegittimità costituzionale.
Differenze con altri organi di controllo.
I membri del consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies) e gli amministratori indipendenti non godono di alcuna limitazione economica, pur esercitando funzioni di vigilanza analoghe.
4. Impatti pratici e prospettive
Sul piano professionale, la riforma offre una tutela maggiore ai sindaci — e indirettamente alle compagnie assicurative — ma rischia di generare effetti ambivalenti.
Nelle società di piccole dimensioni, la ridotta entità dei compensi può rendere irrisorio il limite risarcitorio, attenuando il potere deterrente della norma.
Nelle società più strutturate, al contrario, il danno potenziale da omesso controllo può superare di gran lunga il tetto fissato, lasciando scoperti soci e creditori.
Da qui l’ipotesi che molte imprese, soprattutto medio-grandi, possano rivedere la propria struttura di governance, preferendo affidare la revisione a professionisti esterni non soggetti a limiti di responsabilità o optare per modelli alternativi (monistico o dualistico).
5. Conclusioni
La Legge 35/2025 rappresenta un tentativo di modernizzare la funzione di vigilanza e di rendere sostenibile il rischio connesso all’incarico sindacale. Tuttavia, il quadro che emerge è ancora disomogeneo:
- il sistema “a doppio binario” tra quotate e non quotate crea un’asimmetria regolatoria;
- la convivenza di regimi diversi tra sindaci, revisori e altri organi di controllo rischia di indebolire la coerenza complessiva del sistema.
In assenza di ulteriori chiarimenti interpretativi o linee guida ministeriali, ai professionisti è richiesto di mantenere elevata la qualità della vigilanza, curando la documentazione delle verifiche e la tracciabilità delle decisioni.
Solo così la riforma potrà realmente tradursi in un equilibrio tra protezione del professionista e tutela della collettività societaria.
© FISCALREVISIONE – Riproduzione riservata.